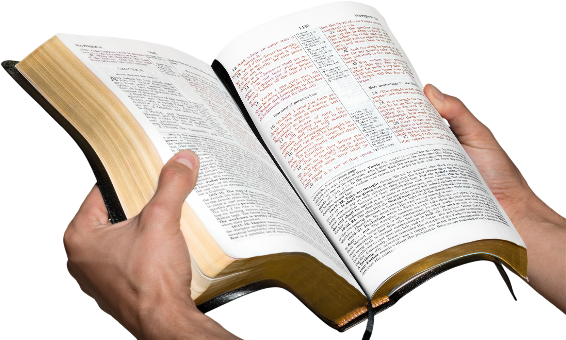SALMO 50
Il Miserere
Il Salmo 50 (o 51 secondo l'enumerazione ebraica) è di una ricchezza inesauribile.
Esso attraversa tutta la storia della Chiesa e della spiritualità: costituisce lo schema interiore delle Confessioni di Agostino.
È soprattutto il salmo che ha accompagnato le preghiere, le lacrime, le sofferenze di tanti uomini e di tante donne che vi hanno trovato conforto e chiarezza nei momenti oscuri e pesanti della loro vita.
Il Miserere è la preghiera dell'uomo di sempre, appartiene alla storia dell'umanità. Meditandolo noi entriamo nel cuore dell'uomo e nel cuore della storia dell'umanità.
1 L'iniziativa divina
I primi versetti del Salmo 50 ci introducono con queste parole:
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Il punto di partenza del cammino di conversione del cuore è l'iniziativa divina di misericordia: Dio è sempre il primo a dare la mano, il piatto della bilancia pende sempre dalla parte della sua bontà.
Il peccato è uno sbaglio fondamentale dell'uomo, una disarmonia, una ribellione, una volontà di progetto alternativo e contrastante il progetto di Dio.
Alle parole che indicano lo sbandamento dell'uomo fanno riscontro tre appellativi divini: «Pietà... misericordia... amore ». C'è il peccato dell'uomo, pur se declinato con termini diversi, e ci sono tre attributi di Dio. Questa sproporzione indica che l'insistenza non è sull'uomo peccatore, sulla povertà di ciò che noi siamo, ma è sull'infinità di Dio.
Dio è dono gratuito, è l'essenza della gratuità.
La seconda parola è « misericordia ». Indica, infatti, l'atteggiamento tipico di Dio verso il suo popolo, che comporta lealtà, affidabilità, fedeltà, bontà, tenerezza, costanza nell'attenzione e nell’amore.
Si potrebbe anche tradurre con «gentilezza», nel senso di tenerezza, che non si smentisce, che non svanisce mai.
Dio è colui che io non conosco, ma per il quale sono importante, per il quale è importante - secondo la parola di Gesù - ogni capello del mio capo. Nulla avviene in me senza un'attenzione della tenerezza di Dio.
La terza parola è «nel tuo grande amore ». È un vocabolo profondamente materno e indica la capacità di portare qualcuno dentro, di immedesimarsi in una situazione così da viverla nella propria carne, da soffrirne o goderne come di cosa propria.
È un vocabolo profondamente materno e indica la capacità di portare qualcuno dentro, di immedesimarsi in una situazione così da viverla nella propria carne, da soffrirne o goderne come di cosa propria.
2 Il riconoscimento della situazione
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e ,nell'intimo m'insegni la sapienza.
Le parole dei primi versetti del Salmo, su cui ci siamo soffermati, ci introducono nella sezione centrale di questo Salmo che si può, utilmente, dividere in tre parti.
La prima parte è il riconoscimento di una situazione. I verbi sono tutti all'indicativo ed espongono, sottolineano dei fatti: riconosco la mia colpa, contro di te ho peccato, sei giusto quando parli, mi insegni la sapienza.
La seconda parte esprime la supplica. Il brano cambia di tono e quasi tutti i verbi sono all'imperativo: purificami, lavami, fammi sentire gioia, distogli lo sguardo, cancella, crea in me, non respingermi, non privarmi, rendimi la gioia, sostieni in me.
La terza parte è il progetto per l'avvenire. I verbi sono al futuro: insegnerò, la mia lingua esalterà.
Con termini a noi più abituali possiamo chiamare: esame di coscienza il riconoscimento della situazione; richiesta di perdono la supplica; proposito il progetto per l'avvenire.
C'è quindi l'io che riconosce, c'è una determinazione generale della situazione di colpa, c'è il Tu con cui termina questa prima parte e che è il punto focale: Tu vuoi la sincerità del cuore, Tu, nell'animo mi insegni la sapienza.
Ecco la chiave della prima parte del Salmo: Dio, nella sua iniziativa di amore e di misericordia, proietta nell'oscurità della mia anima, nel profondo della coscienza, la luce del suo progetto. Così facendo mi porta a scoprire la verità di me stesso, mi dà respiro, mi aiuta a cogliermi rispetto a ciò che sono chiamato ad essere, a ciò che avrei dovuto essere, a ciò che posso essere con la sua grazia.
Non viene, infatti, detto: ho peccato, ho sbagliato. Viene detto: «Contro di te ho peccato ». Le parole del Salmo ci rivelano la differenza tra l'esame di coscienza fatto in dialogo con Dio e tutta l'analisi della colpa, delle debolezze, delle bassezze che ciascuno riconosce in se stesso e che arrivano a deprimere profondamente lo spirito rendendolo ancora più stanco e incapace di lottare.
In questo Salmo, scritto più di duemila anni fa, noi cogliamo l'uomo che ha trovato la via giusta per il pentimento, la via del riconoscimento di colpe gravissime ma espresso davanti a Colui che cambia il cuore dell'uomo.
3 Il dolore dei peccati
Sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio.
Che cosa vuol dire concretamente: «Sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio?». Noi interpretiamo spontaneamente questo versetto mettendo Dio al posto di un giudice; vediamo idealmente due parti convenute in giudizio e Dio nel mezzo.
Le due parti sono, nel caso del riferimento storico del Salmo, Davide e Uria, il marito di Betsabea ucciso proditoriamente per ordine di Davide. Dio sta nel mezzo come giudice imparziale che dà torto a Davide e lo condanna. Il re accetta la condanna e allora dice a Dio: Tu sei retto quando giudichi.
Questa interpretazione non è cogente. Essa pone Dio come arbitro che condanna il peccatore alla morte, senza possibilità di appello.
La realtà vissuta dal Salmo è molto più profonda. Dio non è giudice: è parte lesa. Egli, che è il principio di ogni fedeltà e di ogni amore, è stato leso mortalmente da Davide, è stato violentato nei suoi diritti. Per questo rimprovera Davide e questi accetta il rimprovero sapendo che il giudizio divino è giusto ed è quindi anche un giudizio di perdono.
Dio, come parte offesa, redarguisce Davide perché vuole la sua vita e non la sua morte: se ha tentato di uccidere Dio, Dio lo vuole salvare.
È propriamente a questo punto che scatta il pentimento biblico, il dolore dell'uomo: l'uomo si trova davanti a Colui che ha leso, di cui ha respinto la fiducia e che di nuovo gli offre la mano destra della sua fiducia.
Ci risponderà ancora il Vangelo di Matteo, nella scena del giudizio universale, dove Gesù si costituisce parte lesa ovunque un affamato non è nutrito e un carcerato non è visitato: «In verità vi dico... non l'avete fatto a me » (cfr. Mt. 25, 31-46).
4 La supplica
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.
Cominciamo da una particolarità linguistica che non appare nella versione italiana: siamo di fronte a tre invocazioni di richiesta dello Spirito Santo; da parte dell'uomo. La supplica domanda lo spirito saldo, lo Spirito santo, lo spirito generoso ed è una vera e propria epiclesi.
L'epiclesi liturgica è la preghiera che nella celebrazione eucaristica si fa, al momento della consacrazione, allo Spirito Santo perché scenda in maniera creativa sul pane e sul vino, rendendoli Corpo e Sangue di Cristo.
Qui siamo di fronte ad una epiclesi penitenziale, ad una invocazione dello Spirito perché scenda sulla persona che prega e la trasformi. È quindi il momento culminante del Salmo, come la Consacrazione è il momento culminante dell'Eucaristia.
«Crea in me, o Dio, un cuore puro» è all'inizio dell'epiclesi dello Spirito e l'altra: «Rendimi la gioia di essere salvato» è nel contesto dell'epiclesi stessa. Qual è la domanda fondamentale? Crea in me.
La domanda è quindi di un’azione creatrice, di una novità che Dio solo può porre nell'uomo.
E la parola « crea in me » è parallela con l'altra: « rendimi la gioia ». Non si chiede qualcosa di assolutamente nuovo ma si chiede di far ritornare quel momento creativo originario che è il Battesimo.
Il Sacramento della Riconciliazione è la richiesta di essere reimmersi nella forza creativa dello Spirito battesimale, è una nuova esperienza del Battesimo, che per nostra colpa abbiamo perduta.
Per questo il Sacramento della Riconciliazione non può avere il suo pieno effetto se non abbiamo vissuto profondamente l'esperienza dell'annuncio evangelico, la forza del kerygma.
Come si può restituire ciò che non c'è mai stato o che c'è stato in maniera fiacca, slavata e generica?
Qual è l'oggetto dell'atto creativo e restitutivo che si chiede a Dio di compiere? È un cuore puro, è la gioia.
La gioia è l'esperienza fondamentale che dovremmo recepire in noi. Eppure, tante volte, ripensando alla nostra esperienza cristiana, dobbiamo leggerla come esperienza che si trascina stancamente.
Lo spazio alla gioia è il momento della preghiera, dell'adorazione, del silenzio, del canto, del dialogo sul Vangelo; è il momento del sacrificio, del dono di sé, della rinuncia; è il momento del canto interiore. In questi momenti la gioia, che non è nostra bensì dono gratuito di Dio, scoppia dentro di noi fino a sorprenderci.
« Crea in me, o Dio, un cuore puro... rendimi la gioia di essere salvato.. » È la gioia della salvezza di Dio che mi accoglie, mi ama e mi salva.
5 La confessione dei peccati
Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
Il tema è molto importante per il nostro cammino di riconciliazione. D'altra parte l'accusa dei peccati che il penitente è chiamato a fare di fronte alla Chiesa suscita sempre un senso di disagio e pone diverse domande. Cerchiamo innanzitutto di specificare il disagio e le domande.
Il disagio per il contenuto dell'accusa. Si crea non di rado, in noi, un impaccio perché non sappiamo cosa dire, ci pare di non avere niente da dire. Ci rivolgiamo allora al sacerdote dicendo: «Mi aiuti lei, io non ricordo, non so che cosa dire ».
Il disagio che nasce dalla forma, dall'atmosfera che assume la confessione. Facilmente diventa un'autoaccusa: Ho commesso questo, ho fatto quest'altro, sono colpevole della tal cosa.
In un quadro più psicologico, l'accusa sfocia in un'autocritica che rischia di scivolare verso l'autogiustificazione. Mi sono, cioè, autocriticato così bene da essere riuscito a chiarirmi a me stesso e praticamente non ho più bisogno del perdono di Dio: il perdono diventa accessorio, aggiuntivo e di fatto così si rinnega il Vangelo del perdono.
La prima cosa che notiamo in queste parole è che siamo di fronte ad un movimento dialogico. Qui non c'è autocritica: ho fatto male, ho fatto ciò che non dovevo, ho sbagliato.
Siamo piuttosto in un dialogo intimo e personale: ho fatto ciò che ai tuoi occhi è male. Non ho fatto male soltanto contro la tua legge ma quello che è male «ai tuoi occhi».
L'ambito non è di un solipsismo accusatorio, di un autolesionismo chiuso in se stesso: l'ambito è di un dialogo filiale con Colui che mi ama.
L'esame di coscienza - ora possiamo coglierlo meglio - è il mettersi di fronte alla Parola di Dio non come quadro etico di riferimento, ma come Parola che interpella, che rimprovera con quella forza d'amore che le è propria per fare emergere la scintilla della salvezza e la possibilità del perdono. La confessione e la lode si alternano: l'atmosfera è quella della «confessio laudis» e della «confessio vitae», della confessione di lode e della confessione della vita, non quella dell'autolesionismo e dell'amarezza.
Il confessarsi nella lode era talmente abituale agli Ebrei che persino il fariseo della parabola evangelica fa la sua confessione partendo dalla lode: « Ti ringrazio, mio Dio, perché non sono come gli altri uomini» (Lc 18, 9-14).
L'errore del fariseo, che pure inizia con ringraziare, sta nel congiungere la «confessio laudis » con la « confessio vitae » e nel non mettere davanti alla misericordia e alla bontà di Dio la sua povertà, quella povertà che invece riconosce il pubblicano, con semplicità e coraggio: «Dio, abbi pietà di me peccatore! », che vuol dire: Tu sei grande, misericordioso, potente e io sono povero. Tu mi salvi e io ti lodo per la tua grande potenza. Ecco dunque l'atmosfera, il tono, il ritmo che dovrebbe avere la nostra confessione: l'atmosfera del ringraziamento.
6 La penitenza
Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l'olocausto e l'intera oblazione,
Quando io, come ministro del Sacramento, quindi come confessore, penso alla «penitenza», sento certamente emergere qualche disagio: è forse uno dei momenti che maggiormente mettono in difficoltà il sacerdote.
Egli, infatti, si domanda: Quale penitenza è veramente adeguata al cammino di questa persona che ho davanti?
Tenendo ora presente la difficoltà che la «penitenza» pone al sacerdote che amministra il Sacramento, vi invito a meditare il brano evangelico che parla di Zaccheo (Lc 19, 1-10).
a) L'azione interna che Zaccheo compie è il suo desiderio di vedere Gesù.
- b) L'azione esterna che compie Zaccheo è quella di mettersi a correre e di salire su un albero.
- c)L'azione esterna è che Zaccheo accoglie Gesù, pieno di gioia.
- b) L'azione interna è che Zaccheo decide e comunica di voler dare ai poveri la metà di quello che ha e di riparare i torti in misura straordinaria. La parola di Zaccheo: «Signore, do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto» è la risultanza penitenziale, sociale, civile, comunitaria del cammino di Zaccheo. È il frutto di «penitenza» della sua riconciliazione.
Il primo frutto dell'incontro penitenziale è dunque la gioia, una gioia che deborda, trabocca intorno a noi e che ci fa compiere con facilità azioni anche difficili a cui non ci saremmo mai decisi prima di aver ascoltato la parola di Gesù.
La seconda sottolineatura del cammino di Zaccheo è che lui stesso propone a Gesù la «penitenza» che vuoi fare e Gesù l'approva. Zaccheo propone ciò che è più adatto per un uomo avido, imbroglione, desideroso di possedere come è lui.
Possiamo ritornare alla nostra domanda iniziale: Quale penitenza adeguata al cammino di chi ho davanti posso dare come sacerdote che amministra il Sacramento della Riconciliazione? Come posso aiutare a fare frutti degni di penitenza? La risposta suggeritaci dal brano evangelico è molto semplice. Forse è il penitente che può aiutare me confessore, forse è colui che ha instaurato con me un dialogo penitenziale che può suggerirmi come aiutarlo a fare frutti degni di penitenza.
7 Testimoniare la misericordia
Insegnerò agli erranti le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
...la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
La necessità di essere testimoni della misericordia divina, di vivere la missione della misericordia. Colui che ha percorso il cammino della penitenza sente questa missione come momento conclusivo di ciò che ha fatto e che ha vissuto.
Il salmista esprime il suo impegno missionario in una maniera precisa, che corrisponde all'itinerario da lui percorso: farò capire a chi è senza strada che una strada c'è, anzi che tu, o Signore, gli stai venendo incontro. Lo farò capire non come uno che fa una lezione o una esortazione ma come testimone di ciò che è avvenuto a me.
Ecco allora la forza di questa testimonianza: chi ha percorso un genuino cammino penitenziale, può aiutare altri a capire che c'è una via d'uscita in cui Dio stesso viene incontro, in Gesù, come è venuto incontro a me.
Possiamo subito domandarci: com'è la mia testimonianza? Il Vangelo secondo Giovanni, al c. 4, ci presenta un altro esempio di una bocca che si apre alla testimonianza convinta e convincente: la donna samaritana.
Confrontiamoci con l’esperienza della donna samaritana per scoprire la bellezza e la forza della testimonianza e della gioia della vita nuova.
Cfr Martini Carlo Maria, salmo miserere